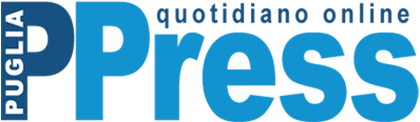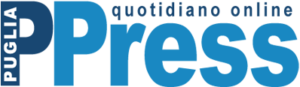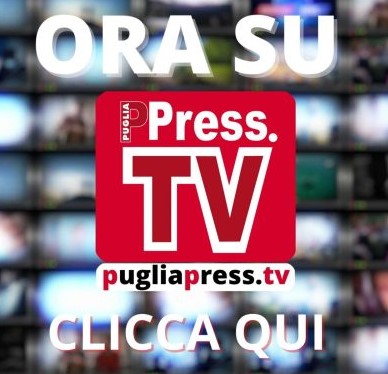Sembra una befana, invece è una Quaremma

Camminando nel periodo pasquale nei centri abitati del territorio salentino, soprattutto di quello leccese ma non solo, è possibile scorgere un fantoccio appeso sui terrazzi, sui davanzali e sui balconi delle case, facilmente confondibile con la classica raffigurazione di quell’anziana signora universalmente nota col nome di “Befana”. Si tratta invece di un pupazzo caratteristico del costume popolare locale, la cui esposizione segna la fine del Carnevale e l’inizio della Quaresima.

Il suo nome è, con tutta probabilità, di derivazione francese, e non è da escludere che abbia a che fare con la presenza nel Salento di soldati transalpini nel XIV secolo (Quaremma, dunque, deriverebbe dal termine Careme, poi tradotto in Quaresima).
Il fantoccio raffigura dunque una vecchia di aspetto orribile, macilenta e certamente dall’aspetto nel complesso un po’ inquietante, vestita di nero per mostrare il lutto (a causa della fine del Carnevale), che secondo la tradizione popolare salentina veniva chiamato “Lu Paulinu”. La stessa espressione popolare “pare na Quaremma” è scherzosamente utilizzata per indicare una donna dall’aspetto trascurato.
Per i piedi si utilizza un paio di calze nere riempite di paglia e attaccate al bordo inferiore dei pantaloni. Alle calze viene infilato un paio di scarpe nere. La testa si ottiene avvolgendo della paglia in un pezzo di stoffa chiara, dando all’insieme una forma ovale. Gli occhi, il naso e la bocca vengono rappresentati attaccando dei pezzi di stoffa ossigenata con vernice nera o carbone. Al fantoccio si fa indossare una veste nera lunghissima che lascia intravedere solo le scarpe; la testa viene avvolta da un fazzoletto nero lasciando scoperto solo il viso; alla Caremma poi viene legato all’altezza della vita un vantili (grembiule) nero e le spalle sono coperte con uno scialle sempre nero.
Questa presenza un po’ sinistra reca nelle mani degli oggetti dal significato altamente simbolico, legati alle tradizioni sacre ma anche popolari: un filo di lana e un fuso nella mano destra, simboli della laboriosità ma anche del passare inesorabile del tempo, con riferimento al filo della vita di ognuno di noi che, secondo la religione pagana, le Parche tendono e tagliano a loro imperscrutabile giudizio.
La mano sinistra, invece, potremmo dire rappresenti il versante cristiano del significato religioso di questa presenza. In essa infatti la Caremma regge un’arancia amara (a volte sostituita da una melograna o da una patata), al cui interno sono inserite sette penne di gallina: numero non casuale, perché corrispondente esattamente alle domeniche che separano il Carnevale dalla Pasqua. Anche l’arancia amara, a ben vedere, ha un significato simbolico: il suo sapore aspro, infatti, indica la sofferenza, la penitenza e il sacrificio che dovrebbero contraddistinguere il periodo della Quaresima. Inoltre, ogni penna di gallina equivale a una settimana di astinenza: infatti, ogni sette giorni ne viene tolta una, fino all’arrivo della Pasqua appunto.
Quando la Quaresima finisce, il filo da tessere ormai si è esaurito, le penne sono terminate e l’arancia amara è diventata secca: a questo punto la Caremma, dopo essere stata spostata dal balcone o dal davanzale, viene esposta su un palo, appesa a un filo. Nel momento in cui le campane cominciano a suonare per dare l’annuncio della Resurrezione di Gesù, il fantoccio viene messo in una piazza e lì bruciato tra scoppi di petardi ed esplosioni di mortaretti: è l’ora della festa, tutti sono felici perché il fuoco simboleggia la salvezza e la purificazione.

Ma gli aspetti ritualistico/simbolici non finiscono qui: il periodo quaresimale rappresenta, come noto, un periodo di sacrificio, che si manifesta anche a tavola: il regime alimentare, infatti, si segnala per una notevole moderazione, che comporta l’eliminazione momentanea dei formaggi, delle uova e della carne. Tutte privazioni che vengono meno nel corso della Settimana Santa, quando ci si dedica anche alla preparazione dei tipici dolci pasquali: uno tra i più famosi e più gustosi è la coddura (a volte indicato come cuddhura o puddica), un dolce di forma rotonda che contiene al proprio interno uova sode ancora nel guscio e che viene regalata dalle ragazze ai propri fidanzati il giorno di Pasqua. Insomma, la Quaremma è parte integrante della cultura del Salento, e lo è ormai da tempo. Già in passato, infatti, essa era posta di solito ai crocicchi il mercoledì delle Ceneri, a segnalare la conclusione delle feste del Carnevale: l’importante era che la sua posizione fosse al centro dell’attenzione, ben visibile, cosìcchè tutti, osservando il fantoccio, ricordassero la necessità del sacrificio tipica della Quaresima.